 Localizza monumento
Localizza monumento
Localizza il monumento
 Informazioni storiche
Informazioni storiche
Informazioni storiche artistiche sul monumento★ ☆ ☆ ☆ ☆
Monumento Scomparso!
Codice identificativo monumento: 19915
 Cronologia
Cronologia
8/1896
Presso la via della Moletta, circa mezzo chilometro fuori della porta s. Paolo, per i lavori del grande collettore delle acque sulla riva sinistra del Tevere, è stata scoperta l'arcata dell'antico ponte della via Ostiense, sotto il quale correva il fiumicello Almone, I piloni laterali del ponte, costruiti a grandi massi rettangolari di tufo, sono quasi totalmente distrutti. L'arco è formato anch'esso da blocchi di tufo, con la chiave centrale in travertino, e la sua luce misura m. 7,60.
L'arcata opposta, dal lato destro della strada, è assai meglio conservata, ed è rimasta sempre visibile nella vigna di Tor de’ Specchi. Dista da quella ora scoperta poco più di 15 metri; con la quale misura viene determinata la larghezza dell'antico ponte e della via Ostiense.
Fra le terre asportate nello sterro furono raccolti due frammenti di cornice mormorea, sagomata; un pezzo di avambraccio, spettante a statua panneggiata; un manico di anfora, su cui è impresso il bollo CAP; un'arca fittile, lunga m. 1,00 X 0,53 X 0,42,
Giuseppe Gatti.
Fonte: Notizie degli scavi di antichità
11/1898
In altri fascicoli di queste Notizie è stato dato esatto conto delle varie scoperte avvenute tra il primo ed il terzo chilometro della via Ostiense, in seguito agli scavi per la costruzione del collettore principale sulla sponda sinistra del Tevere. E come fu accennato (p. 190 sg.) l'importanza di tali scoperte dipendeva essenzialmente dalla questione relativa all'andamento dell'antica via Ostiense nel punto in cui trovasi la basilica di s. Paolo.
silica medesima, dapprima incerto e in più modi proposto dagli scrittori di topografia, sì potè con precisione riconoscere in questi ultimi mesi, mercè le scoperte che dettero occasione alle dotte note postume del compianto comm. E. Stevenson, intitolate: Osservazioni sulla topografia della via Ostiense; edite nel Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana, anno III, pagg. 283-321.
L'antica via, a partire dal recinto di Aureliano fino quasi alla basilica di s. Paolo, seguiva esattamente il percorso della strada moderna, come è testimoniato da pochi, ma ineccepibili capisaldi che sono: 1° il sepolcro dei Claudii, a destra della via, poco prima del ponte della ferrovia Roma-Civitavecchia; 2° il rudere di grandioso monumento sepolcrale, a sinistra della via, appena oltrepassato lo stesso ponte ferroviario; 3° i cippi terminali del Tevere rinvenuti presso l'Almone, sul margine destro della via, nel terreno di proprietà del Monastero di Tor de' Specchi; 4° il vetusto ponte sull'Almone (oggi ponte della Moletta).
Questo ponte, di cui conoscevasi solo l'estremità sul lato destro della via, fu interamente scoperto due anni or sono, pei medesimi lavori del collettore. I piloni laterali sono costruiti a grandi massì rettangolari di tufo, e l'arco, la cui luce è di m. 7,60, è anch'esso formato di blocchi di tufo con chiave centrale di travertino. La larghezza del ponte è di metri 15, misura importante per determinare anche la larghezza dall'antica via Ostiense, nel punto ove valicava l'Almone.
Maggiore difficoltà presentava, come abbiamo detto, la questione circa l'andamento della via dopo il primo milliario, ossia nella località che è divenuta così celebre nella storia, per la tumulazione dell'apostolo s. Paolo nel cimitero di Lucina.
È noto, che la primitiva basilica, fatta erigere dall'imperatore Costantino, era di tanto modeste proporzioni, da giungere appena alla confessione della chiesa odierna. E poichè l'abside della basilica costantiniana era rivolto a ponente fu supposto che la via Ostiense dovesse passare innanzi alla fronte del primitivo tempio cristiano, seguendo il percorso della via attuale, cioè fra il colle e la chiesa.
L'anno 386, con editto speciale degli imperatori Onorio, Teodosio e Valentiniano II, indirizzato a Sallustio prefetto di Roma, la basilica dell'apostolo fu ricostruita dalle fondamenta ed in proporzioni assai più vaste e con inaudita magnificenza. In seguito a tali opere fu invertita l'orientazione della basilica, pur conservando l'antica confessione nel suo posto primitivo. Ed è assai verosimile il supporre, che la via Ostiense fosse, in quella occasione, deviata a ponente, in modo da farla passare dinanzi al portico della nuova basilica teodosiana.
Abbiamo quindi da considerare due casi cioè, se l'Ostiense passando dinanzi alla primitiva basilica costantiniana, seguisse l'andamento della via attuale, ovvero se alla fine del secolo IV fosse spostata e fatta passare tra la fronte della nuova basilica teodosiana ed il Tevere, siccome recisamente afferma il Nibby.
Ma v'ha una terza considerazione. Negli scavi eseguiti l'anno 1850 per la ricostruzione del tempio teodosiano, distrutto dal fatale incendio del 1823, fu riconosciuta l'esistenza di un'antica via, il cui selciato, a poligoni di lava basaltica, fu trovato proprio dietro l'abside della basilica costantiniana, nella crociera o nave transversa della chiesa attuale e quasi sotto l'arco trionfale decorato dei mosaici di Leone Magno.
E la via era fiancheggiata da sepolcri e colombai, uno dei quali, conservatissimo, fu scoperto vicino alla tomba dell'apostolo. Quale era dunque questa via, parallela ed a brevissima distanza dalla Ostiense?...
In tutto ciò osservo anzitutto, che la stessa solennità con la quale parlasi, nell'editto, di quella strada che intendevasi di abbandonare, anzi di sopprimere, sî placeret tam populo quam Senatui, esclude trattarsi di una via secondaria e di poca importanza. Quindi l'iter vetus altro non è se non la via Ostiense primitiva, la quale, in seguito ai grandi lavori del secolo IV, fu trasferita tra l'abside della basilica teodosiana ed il colle, e dove ancor oggi la sì trova.
Una sola obbiezione potrebbe farsi ed è, che Costantino avrebbe edificata la basilica dell'apostolo in modo da far passare una via pubblica e della importanza della Ostiense, proprio dietro l'abside anzichè dinanzi alla facciata. Ma a parte che ciò riscontrasi anche nella basilica costantiniana di s. Agnese, dietro la cui abside corre la Nomentana, tale fatto era assai naturale poichè, se la basilica racchiudeva nella confessione la cella sepolcrale in cui la pia Lucina depose il corpo dell'apostolo delle genti, e se dietro l'abside costantiniana correva la via Ostiense, è segno manifesto, che il sepolcro trovavasi sulla sinistra della via, per chi muoveva dalla città.
Ed ecco perchè la basilica di Costantino fu costruita colla fronte a levante; altrimenti la via pubblica avrebbe impedito il libero svolgimento dell'edificio. Parmi quindi si possa concludere, in modo non dubbio, che la via Ostiense primitiva passò più ad occidente dell'attuale, e che questa, a sua volta, segue esattamente il percorso tracciato alla fine del secolo IV, in seguito ai lavori pel nuovo tempio, iniziati per ordine di Teodosio l’anno 386.
E che il tratto di via scoperto sotto la nave transversa della basilica nel 1850, appartenesse appunto alla Ostiense, è confermato dal fatto che i varî sepolcri, quasi tutti colombai, scoperti presso il bivio formato dalla via delle Sette Chiese e dietro
la stessa basilica di s. Paolo, non erano normali con l'asse della strada odierna, ma accennavano chiaramente ad una via che passava un poco più ad occidente, sotto la basilica stessa, dove fu infatti riconosciuta nel ricordato anno 1850. Altro importante avanzo della via è stato ora scoperto appena oltrepassato il convento annesso alla basilica, sotto la strada moderna, nel punto indicato colla lettera B. Del selciato rimanevano ancora al posto varî poligoni di basalte, limitati, sul margine destro della via, da un muraglione composto di grossi blocchi tufacei, lungo, nella parte scoperta, m. 14. I blocchi erano disposti nel senso della lunghezza, in due ordini sovrapposti, della larghezza di m, 1,80, e posavano su di una platea di calcestruzzo (fig. 2).
L'altezza di questo muraglione, che è di m. 0,80 sul piano stradale, e la sua struttura, escludono trattarsi di una delle solite crepidini. Sembra invece che si tratti di una specie di diga per proteggere la via dalle acque alluvionali del vicino Tevere. Questa parte del suburbio attraversata dalla Ostiense, ed alla quale si dà volgarmente il nome di Prati di s. Paolo, ha infatti la particolarità di essere mollo depressa e per di più solcata da copiosi fossati che convogliano al Tevere le acque che scaturiscono alle falde delle colline dell'Annunziatella e di Grotta Perfetta. Ed anche oggi, nonostante che il terreno siasi notevolmente alzato sul piano antico. questa località è tra le prime ad essere inondata dalle acque straripanti del fiume.
Del resto che questo terreno fosse stato sempre acquitrinoso, si dimostra con documenti irrefutabili così antichi come dell'età di mezzo, i quali fanno menzione di molti horti quivi esistiti; nè è improbabile che nell'età classica qui appunto si trovassero gli horti olitorii, ricordati nella bella lapide riproducente il libello di Geminio Eutichete.
Il percorso dell'antica Ostiense, ora riconosciuto, fa anche rilevare come gli antichi avessero interrotto il rettifilo per l'ostacolo frapposto dalla presenza del colle retrostante alla basilica e che oggi vien denominato colle di s. Paolo. Evitato questo colle con una curva ad occidente, la via proseguiva nella direzione della strada attuale sino al bivio della Laurentina; come è stato testimoniato dai cippi, molti dei quali ancora 27 stu, scoperti negli stessi prati di s. Paolo, nel punto indicato nella pianta (fig. 1) con la lettera C.
Al bivio della Laurentina troviamo un altro caposaldo nel ponte che dà il nome alla località (il Ponzicello) e sotto il quale scorre l'acqua del fosso di Grotta Perfetta. È solidamente costruito a blocchi di tufo, cuneati; e secondo il Nibby fu costruito sul principio del I secolo dell'impero. L'opera laterizia, alla testata occidentale, devesi invece giudicare un restauro od ingrandimento dell'età severiana.
I recenti rinvenimenti ci conducono ora al quarto termine chilometrico della via, nella località di Ponte Fratta, ove era il vicus Alexandri, specie di sobborgo originato da uno scalo o porto fluviatile, frequentatissimo e di grande rinomanza nell'antichità.
Ora proprio innanzi al cancello di vigna Venerati e rimpetto agli avanzi del mausoleo di Marco Antonio Lupo, a m. 46,20 di distanza, verso il Tevere, è stato riconosciuto un nuovo tratto della Ostiense, per la lunghezza di m. 11 circa, e con il selciato ancora in buona conservazione. Sul margine destro ricorreva, come nel tratto di via scoperto nel punto B, la solita diga formata di blocchi di tufo, disposti anche qui in due file, larga m. 1,60 e che si elevava per m. 0,90 sui poligoni di basalte del selciato.
Infisso ancora al posto, a contatto di questo riparo a blocchi di tufo, era un cippo di travertino, alto m. 1,10, largo m. 0,59, dello spessore di m. 0,15, con la parte inferiore grezza, perchè rimaneva nascosta nel terreno. Dal lato che era rivolto alla via leggesi a grandi lettere: VIA LATA PXXXV
È da notare infine, che la strada antica trovasi ad un livello di circa 4 metri più basso della via moderna. E l'averla rinvenuta assai più vicino alla sponda del fiume è argomento per ritenere che corresse in direzione della città, seguendo un percorso meno irregolare di quello della strada moderna, non dovendo esistere, in antico, quella acuta risvolta che fa ora il fiume a Ponte Fratta, ove l'acqua giunge quasi a lambire la collina.
Luigi Borsari.

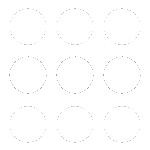




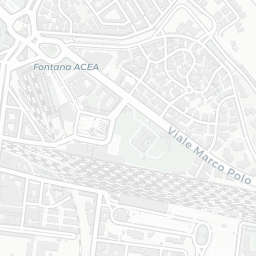







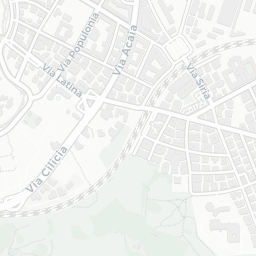

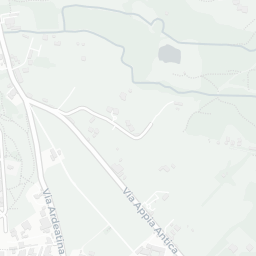


 Guarda in altre Mappe
Guarda in altre Mappe  Dal Centro
Dal Centro Indirizzo: Via Ostiense
Indirizzo: Via Ostiense Esplora nelle vicinanze
Esplora nelle vicinanze  Condividi pagina
Condividi pagina 












